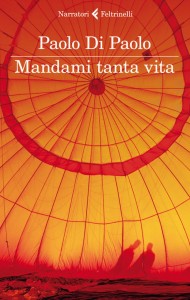 La giovinezza non può attendere: vive, scoppia, si espande, irrompe, nonostante l’insidia di anni carichi di funesti presagi.
La giovinezza non può attendere: vive, scoppia, si espande, irrompe, nonostante l’insidia di anni carichi di funesti presagi.
È la giovinezza ardente e generosa di Piero, che si guarda attorno nella sua Torino grigia e un poco uggiosa degli anni Venti del Novecento, ma contemporaneamente guarda lontano e non si lascia chiudere l’orizzonte da un ambiente che si farà sempre più minaccioso e ostile.
Per questo, “un po’ Mazzini, un po’ Charlot”[1], andrà a Parigi, la città dove “girano come cani randagi poeti e pittori morti di fame”[2] e anche esuli affamati di libertà: “Non è la libertà, ciò a cui va incontro?”[3].
Egli è animato da grandi ideali e possiede la forza dell’intelligenza e della parola, le sue armi contro l’ottusità e la violenza che contribuiranno, sì, alla sua fine precoce, ma non potranno impedirgli di arrivare al futuro, lasciando un esempio che agirà come lievito nella formazione della coscienza morale e politica delle nuove generazioni.
E non può aspettare il cuore, che si affida con lucidità e tenerezza alla giovane Ada (“Purché piaccia ad Ada, io sono contento”[4]), lei, che “nel bambino chiuso, nel ragazzino sfottente che Piero era stato, aveva aperto un varco”[5], Ada, nome che “gli sembrava di leggere nell’insegna dei negozi, nei cartelloni delle strade, breve, sconfinato… e si sentiva di stare al sicuro in quel nome come in una tana”[6]; giovane sposa e compagna di speranze e di dolori, “ragazza che da qualche mese era già madre da sempre”[7], destinata a restare troppo presto sola con Paolo, il loro Pussin, pulcino, che non conoscerà suo padre e che il padre voleva che restasse italiano.
Sono pochi ma maturi gli anni di Piero (e quanto testimonia a riguardo la sua biblioteca, che contiene Serra, Tasso, De Sanctis, Papini!); sono pochi, ma l’intensità (“Partiva per Firenze, per Roma, vedeva Salvemini, vedeva Gentile”[8]…) e la caparbietà con cui sono vissuti (“Basta volerle le cose…Basta infinitamente volerle”[9]) sembrano moltiplicarli e infittirli, dando compiutezza a un’esistenza tanto breve.
Parallelamente alla sua si svolge la vita di Moraldo, giovane studente di Lettere che, dopo una prima fase di istintiva antipatia, ammira e segretamente un poco invidia le qualità di Piero, che vorrebbe incontrare e magari imitare, ma che le strane alchimie del caso gli consentono solo di sfiorare; tuttavia, forse, la notizia della sua morte darà finalmente una sferzata e una direzione al futuro di Moraldo, bloccato dall’indecisione e avvolto nell’incertezza: l’altra faccia dell’età giovanile.
A lui, nel gioco degli incontri orditi dalla sorte, una valigia scambiata aveva fatto conoscere una giovane fotografa, Carlotta, ma non era stato l’amore: di lei gli sarebbe rimasto un “ritaglio di fotografia davanti agli occhi, come un santino nelle mani di chi sente di aver perso Dio”[10]. Moraldo dovrà faticosamente imparare che è più facile ritrovare una valigia smarrita che la propria strada e se stessi.
Paolo Di Paolo, in questo libro interamente giovane, ma artisticamente maturo, soprattutto nella naturalezza con cui il dato storico si fa elemento elegiaco e il lirismo del linguaggio si fonde con la sua nitida precisione, trasforma la vicenda straordinaria e drammatica di Piero Gobetti in un paradigma di giovinezza pienamente vissuta, appassionata e struggente nella sua tragica brevità, destinata a dilatarsi ed estendersi in molte altre future giovinezze.
[1] P. Di Paolo, Mandami tanta vita, Feltrinelli, Milano 2013, p. 73.
[2] Ivi, p. 78.
[3] Ivi, p. 50.
[4] Ivi, p. 88.
[5] Ivi, p. 89.
[6] Ivi, p. 91.
[7] Ivi, p. 31.
[8] Ivi, p. 47.
[9] Ivi, p. 31.
[10] Ivi, p. 149.




