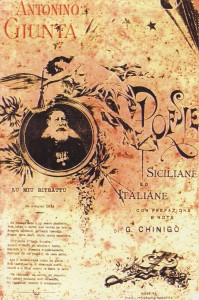Un uomo energico e volitivo come Giunta (‘nnatu ‘ntra mari, curru, sautu, ammuttu[1] – Lu ritrattu propriu, Autoritratto, v. 4) non può non colpire l’accidia incarnata da Pitrazzu che, per non cucinare, sarebbe disposto a mangiare sempre fichi[2] e non desidera altro che mangiare, bere e coricarsi (manciu, bivu e mi curcu – Pitrazzu o l’accidia, v. 40); il pigro, però, finisce male:
Un uomo energico e volitivo come Giunta (‘nnatu ‘ntra mari, curru, sautu, ammuttu[1] – Lu ritrattu propriu, Autoritratto, v. 4) non può non colpire l’accidia incarnata da Pitrazzu che, per non cucinare, sarebbe disposto a mangiare sempre fichi[2] e non desidera altro che mangiare, bere e coricarsi (manciu, bivu e mi curcu – Pitrazzu o l’accidia, v. 40); il pigro, però, finisce male:
cu non suda, non stenta e non travagghia,
mori, comu Pitrazzu, ‘ntra la pagghia.[3] (La morte di Pitrazzu, vv 7-8)
Opposto a Pitrazzu è Miciu Botta, che non si prende mai una sosta dalle sue frenetiche attività, e sembra di vederlo mentre
fa catinazzi, chiavi, chiova e tacci,
pisca a totani, a grunghi a vopi a sicci,
bannia murini, cefali ed alacci,
metti ‘nsalmura sardi, sauri, alicci.[4] (Miciu Botta, vv. 2-5)
Niente da prendere, invece da Mastru Brasi, che “si senti un Bonaparti”[5] (v. 5),
ma tannu mastru Brasi ‘mpara l’arti
quann’arrisuscitannu scecchi morti.[6] (Mastru Brasi, vv. 7-8)
Ancora peggio l’imbecilli, che, non avendo idee proprie, vaga come cosa senza peso fra il “sì” e il “no” e il poeta lo colpisce nella sua insignificanza con versi fulminanti:
‘Na picca dici: sì, ‘na picca no,
ora sì, ora no, ora no e sì;
si dici sì, non si sapi s’è no,
si dici no, non si sapi s’è sì,
tantu a lu cozzu ci pisa lu no,
quantu a li corna ci pisa lu sì;
quannu fu ‘mpastizzatu stu sì e stu no
so matri dicia no, so patri sì.[7] (Ad un imbecilli)
Ilare e scanzonata, tale da suscitare puro divertimento, è la descrizione del “nasu di Paddazzu”:
Lu nasu di Paddazzu è straurdinariu,
ssimigghia un turriuni o prumuntoriu
…………………………………..
Di punta, pari turri di Surrizzu,
di longu pari capu di Milazzu,
di ciancu, la scugghera di lu Pizzu,
di frunti, di Caserta lu Palazzu.[8] (Lu nasu di Paddazzu, vv. 1-2; 9-12)
Un atteggiamento altrettanto divertito si nota nel sonetto Pri la morti di Lucchisi, morte che, insinua maliziosamente il poeta, coglie il protagonista, un venditore ambulante, a causa delle maledizioni dei compaesani assordati dalla sua voce petulante, aspra e molesta:
Tantu fu pitulanti, aspra e mulesta
la vuci, chi assurdò vaneddi e strati,
chi ogn’unu dissi :Oh ci vegna ‘na pesta
a Lucchisi,a lu sceccu e a li patati.
………………………………………
Ed ora in santa paci si po stari
di notti e jornu, di stati e d’invernu,
ca un si senti Lucchisi chiù abbanniari.[9]
Ancora più grave, perché avrebbe dovuto produrre suoni armoniosi, il danno causato dalla banna di Samperi, di fatto in tutto simile a quello provocato da un terremoto:
Ddu frastonu di musica infirnali
ca s’intisi ntrall’uri vespertini,
chi pr’un essiri affattu musicali
rumpia di la pacenza ogni cunfini,
fu a cunfruntu lu mancu d’ogni mali,
e giustu è chi a lu peggiu un c’è mai fini,
ch’unni passa la banna di Samperi
sdirrupa casi, cunventi e quarteri.[10] (La banna di Samperi)
(continua)
[1] Nuoto in mare, corro, salto, sollevo.
[2] Jeu non disiu stuffatu e maccarruni,
ca su nimicu di lu cucinari,
vurria un tirritoriu di ficari
senz’umbra di patruni (Pitrazzu o l’accidia, vv.1-4 ).
Io non desidero stufato e maccheroni,/ perché sono nemico del cucinare,/ vorrei un terreno coltivato a fichi/ senza l’ombra di un padrone.
[3] Chi non suda, non soffre stenti e non fatica,/ muore come Pitrazzu nella paglia.
[4] Fa catenacci, chiavi, chiodi e bullette,/ pesca totani, gronghi, boghe, seppie,/ urla murene, cefali e lacce,/ mette in salamoia sarde sgombri, alici.
[5] Si ritiene un Buonaparte.
[6] Allora mastro Brasi imparerà il mestiere,/ quando risusciteranno asini morti.
[7] Un po’ dice sì, un poco no,/ ora sì, ora no, ora no e sì;/ se dice sì, non si sa se è no ,/ se dice no, non si sa se è sì,/ tanto sul collo gli pesa il no,/ quanto sulle corna gli pesa il sì;/ quando fu impastato questo sì e no/ sua madre diceva no, suo padre sì.
[8] Il naso di Paddazzu è straordinario,/ assomiglia a un torrione o promontorio…/ Di punta sembra la torre di San Rizzo,/ di lungo sembra il capo di Milazzo,/ di fianco la scogliera del Pizzo, di fronte, la Reggia di Caserta.
[9] Tanto fu petulante, aspra e molesta/ la voce che assordò vicoli e strade/ che ognuno disse: Possa venire un accidenti/ a Lucchisi, al suo asino e alle patate…/ E ora si può vivere in pace/ di notte e di giorno, d’estate e d’inverno,/ perché non si sente più urlare Lucchisi (vv.1-4; 9-11).
[10] Quel frastuono di musica infernale/ che si è udita all’ora del vespro,/ e, non essendo affatto melodiosa,/ rompeva tutti i confini della pazienza,/ è stata in confronto il minore dei mali,/ ed è proprio vero che al peggio non c’è fine:/ infatti, dove passa la banda di Samperi,/ fa crollare case, conventi e quartieri.