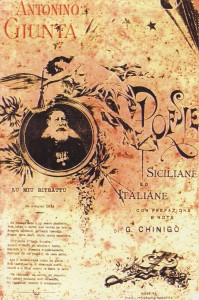Vivace e leggero, dunque, il poeta odia tutto ciò che, secondo lui, è serioso e ipocrita : così, ad esempio, attacca i preti:
Vivace e leggero, dunque, il poeta odia tutto ciò che, secondo lui, è serioso e ipocrita : così, ad esempio, attacca i preti:
Li parrini su niuri e su curvuni
cud’iddi ‘un bisugnaticci truzzari,
chi quann’anchi un v’arrivanu a bruciari,
vi tincinu e vi fannu mascaruni.[1] (Li parrini)
Lo stesso pessimismo traspare, a volte, nei confronti della politica e, nel componimento dedicato a Valerio Mezzanotte, il deputato che aveva scoperto il disavanzo di centocinquanta milioni, riprende Dante per affermare malinconicamente:
Ma sarà sempri Italia
burdellu di pruvincia. (A Valeriu Mezzanotti, vv. 50-51)
Egli ribadisce la propria onestà non solo nel verso già citato dell’Autoritratto, ma anche in un distico, Furtuna onesta, in cui afferma:
Si onestamenti non si fa furtuna,
non vogghiu in vita mia farni manc’una.[2]
Non così il suo Salvaturi Terranova, un imbroglione che sembra un birillo, scivola e tergiversa come un’ anguilla e burla il prossimo:
paratu supra un pedi pari un brigghiu
comu n’anghidda sciddica e sfirria
……………………………………
sputa, vi ridi ‘facci e vi babbia.[3] (A Salvaturi Terranova, vv. 3-4; 6)
Un grande imbroglione, oltre che appassionato di pesca, è anche Padri Don Vincenzu, lu munsignaru (il bugiardo), sul cui sepolcro il poeta immagina che, un giorno, saranno scolpiti, oltre all’immancabile croce, anche nasse, fiocine e ami e, insieme, la menzogna, che non si dà pace, perchè ha perso l’amico più gradito:
Quannu chi Don Vincenzo scatta ’mpaci,
supra lu sò sepulcru, oltri la cruci,
nassi, friccini, ’nganni, anci e camaci,
si sculpirannu…
………………………………………
e la minsogna, chi un si duna paci,
pr’aviri persu l’amicu chiù duci.[4] (A Padri Don Vincenzu, vv. 1-4; 7-8)
Singolare intreccio fra arnesi usati per ingannare i pesci e reti tese a danno dei propri simili!
Il cappellano, invece, sopravvaluta le sue capacità oratorie, crede di avere una grande mente e di godere del favore della musa, e non si accorge di provocare nei presenti la febbre sporadica e di generare sbadigli, stiramenti del corpo, noia e sonno, anche perchè, non avendo più una radice di dente o molare,si ingarbuglia maledettamente:
Cridendusi di menti encicopletica,
cu li favuri di la musa arcatica,
quannu si vota ‘chiesa e fa la predica
ci veni a tutti la frevi spuradica;
facennu fflù fflù fflù tuttu s’impedica
chi chiù di moli e denti un’avi radica,
e ‘ntra sbadagghi e ‘tra stinnicchia a milia,
ogni lissa,siddii, sonnu cuncilia.[5] (Lu cappillanu, vv.1-8)
E poi c’è Ciccu, che ha meno senno dell’asino con il quale vive a stretto contatto e vale, quindi, meno della sua bestia:
Anni, n’avi chiù Ciccu ca lu sceccu,
ma giudiziu, lu sceccu chiù di Ciccu;
e ddi tri franchi chi vali lu sceccu
non vali mancu lu poviru Ciccu.[6] (Ciccu e l’asinu, vv. 5-8)
Il suo verso si vela, invece, di tristezza quando parla dei sogni infranti dei poveri diavoli, che, come Piddirinu, inutilmente piantano cavoli per sfuggire alla fame: ci saranno sempre “li ciuccazzi spinnacchiati e mauli”[7] (v. 3) che, “comu tanti diavuli”[8] (v. 5), ne divoreranno la fatica. Così, il povero Piddirinu ha maturato la sua amara filosofia:
…a sparapauli
sempri lu celu manna affanni e triuli.[9] (Lu disignu di lu poveru, Il disegno del povero, vv. 7-8)
(continua)
[1] I preti sono neri, sono carbone/ con loro non bisogna entrare in contatto,/ perché, anche se non arrivano a bruciarvi,/ vi anneriscono e vi rendono deformi come maschere.
[2] Se con l’onestà non si fa fortuna,/ in vita mia non voglio farne nemmeno una.
[3] Stando ritto su un piede sembra un birillo/ scivola e tergiversa come un’anguilla/…/ sputa, vi ride in faccia e si prende gioco di voi.
[4] Quando Don Vincenzo creperà/ sopra il suo sepolcro, oltre alla croce/ si scolpiranno…/ nasse, fiocine, inganni, ganci e ami/…/ e la menzogna, che non si dà pace/ per avere perduto l’amico più caro.
[5] Credendosi di mente enciclopedica,/ benvoluto dalla musa arcadica,/ quando in chiesa si gira e fa la predica/ viene a tutti la febbre sporadica;/ facendo flù flù flù s’ingarbuglia tutto/ perché non ha più una radice di molari e denti,/ e tra sbadigli e stiramenti a non finire,/ concilia ogni noia, tedio e sonno.
[6] Di anni, ne ha più Cicco dell’asino,/ ma di giudizio ne ha più l’asino;/ e quei tre franchi che vale l’asino/ nemmeno li vale il povero Cicco.
[7] Le brutte chiocce spennacchiate e stecchite.
[8] Come tanti diavoli.
[9] Ai poveri/ sempre il cielo manda affanni e triboli.